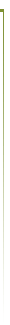
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|

2003 |
|
|
|
POLITICA |
 |
|
Chi pensa agli agricoltori? |
La recente riforma della pac
è imperniata su azioni tese a evitare distorsioni negli scambi commerciali e a
favorire nel contempo le richieste di qualità e sicurezza del consumatore. Non
si preoccupa, di fatto, del reddito degli agricoltori
Il 26 giugno scorso si è
conclusa la maratona sulla proposta di riforma della politica agricola comune,
avanzata dal commissario Franz Fischler circa un anno fa. È stata una battaglia
dura, alla fine della quale tutti vorrebbero potersi chiamare vincitori. In
Italia si è sempre considerato che i contendenti più forti fossero, da un lato,
il commissario Fischler e, dall’altro, il cosiddetto blocco franco-tedesco
schierato, soprattutto, a difesa degli interessi degli agricoltori francesi. Se
si va sul sito Internet della Fnsea (www.fnsea.fr), la grande organizzazione
degli agricoltori francesi, si può leggere un’intervista rilasciata dal
presidente Jean-Michel Lemetayer il 27 giugno dal titolo «Una vera rinuncia
alla gestione dei mercati», nella quale egli esprime un giudizio tutt’altro che
positivo su quanto ottenuto dal ministro dell’agricoltura francese e
soprattutto dal presidente Jacques Chirac. In conclusione, nemmeno il blocco
franco-tedesco, dopo aver ottenuto nel Consiglio di ottobre il congelamento del
budget di spesa per gli interventi di mercato fino al 2013, è riuscito a
scalfire la resistenza di Fischler, soprattutto sul disaccoppiamento.Le ragioni sono chiaramente
espresse nella seconda pagina dell’allegato al «Compromesso» del 26 giugno,
dove sono elencati gli obiettivi. Secondo il documento: la riforma è la
risposta alle richieste dei cittadini di cibo più sano, di migliore qualità, di
metodi di produzione rispettosi degli animali e dell’ambiente, di mantenimento
delle nostre condizioni di vita naturali e di protezione delle campagne. Essa
contribuisce a migliorare l’immagine pubblica e il ruolo degli agricoltori
nella società europea, consentendo di accrescere il consenso dei consumatori
nei confronti della pac e la disponibilità dei contribuenti a pagare tale
politica. Lancia, inoltre, un messaggio ai partner commerciali, compresi, in
particolare, i Paesi in via di sviluppo, perché implica un netto scostamento
dal sostegno agricolo accoppiato causa di distorsioni degli scambi e un’ulteriore
riduzione dei sussidi all’esportazione. Il Consiglio sottolinea, poi, che la
riforma consente di ridurre le rimanenti distorsioni commerciali e che la spesa
globale si manterrà nell’ambito dei massimali convenuti. La riforma
costituisce, infine, l’importante contributo dell’Europa all’agenda di Doha e
definisce i limiti dell’ambito del negoziato della Commissione nel quadro del
round Wto.
Il compromesso conclude
l’elenco degli obiettivi affermando che ogni Paese ha diritto a una politica
agricola propria, a condizione che sia sostenibile ed eviti le distorsioni
commerciali: «il sostegno che l’Ue (esattamente come altri) offre ai suoi
agricoltori è una scelta politica fondata sull’obiettivo di garantire
un’agricoltura sostenibile nei suoi aspetti sociali, economici e ambientali».
Dalla lettura di queste frasi
emerge chiaramente che la riforma della pac per i 15 Paesi della vecchia Ue non
è stata pensata per gli agricoltori rimasti ma che, dati i vincoli di bilancio
malgrado l’entrata di altri 11 Paesi, questa riforma ha per obiettivo un nuovo
rapporto tra agricoltura e società civile e l’allargamento degli scambi a
livello mondiale nel comune interesse dei Paesi ricchi e dei Paesi poveri. È
una riforma della politica agricola comune che, di fatto, non si preoccupa del
reddito degli agricoltori, che certamente non vuole penalizzarli, ma che ha
pensato le azioni di politica agraria di cui si compone (in particolare il
disaccoppiamento) soprattutto per evitare le distorsioni agli scambi, di cui le
misure accoppiate erano responsabili, e affida alla cosiddetta politica del
«secondo pilastro» gli interventi diretti a far crescere la competitività delle
imprese e a orientarne la produzione secondo le richieste (qualità e sicurezza)
del nuovo consumatore e i bisogni (ambiente) della società civile.
Il problema sta proprio qui:
chi pensa agli agricoltori? L’agricoltura in questi anni è diventata un’altra
cosa rispetto a quella che aveva bisogno di una politica orizzontale di
sostegno dei prezzi per mantenere sul mercato le aziende efficienti e anche
quelle marginali; allo stesso tempo sono cambiati i bisogni di una società
civile che, soddisfatti i bisogni primari, domanda ora qualità, sicurezza e
ambiente. L’ultimo Censimento ha messo in evidenza che la nostra agricoltura è
fatta da tante aziende piccole e piccolissime (1.160.000 sono sotto l’ettaro) e
da poche aziende professionali. Il disaccoppiamento rischia di spingere le
prime verso la «non coltura», mentre per le seconde, proiettate sul mercato, il
pagamento unico non basta per modificare le condizioni di convenienza
dell’attività di impresa, ma sarà necessario un forte intervento di carattere
strutturale e un efficace miglioramento dell’organizzazione di mercato.
|
|
|  |
|
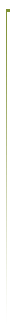

|